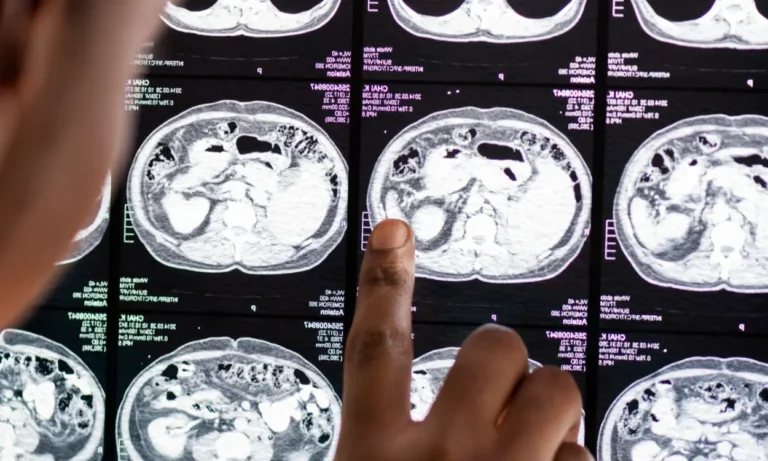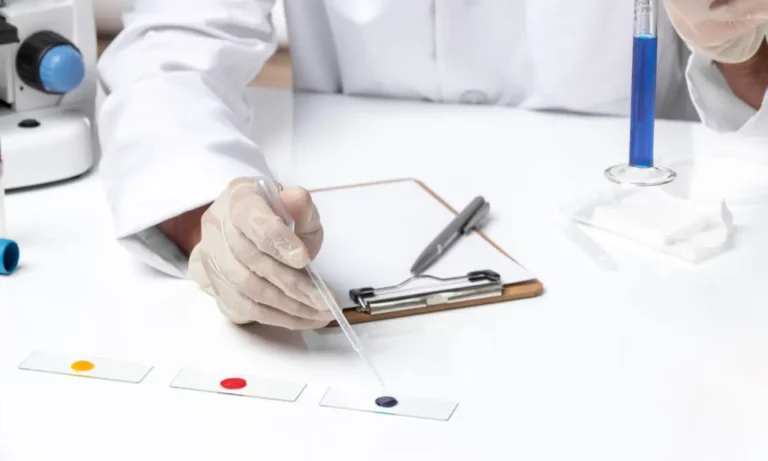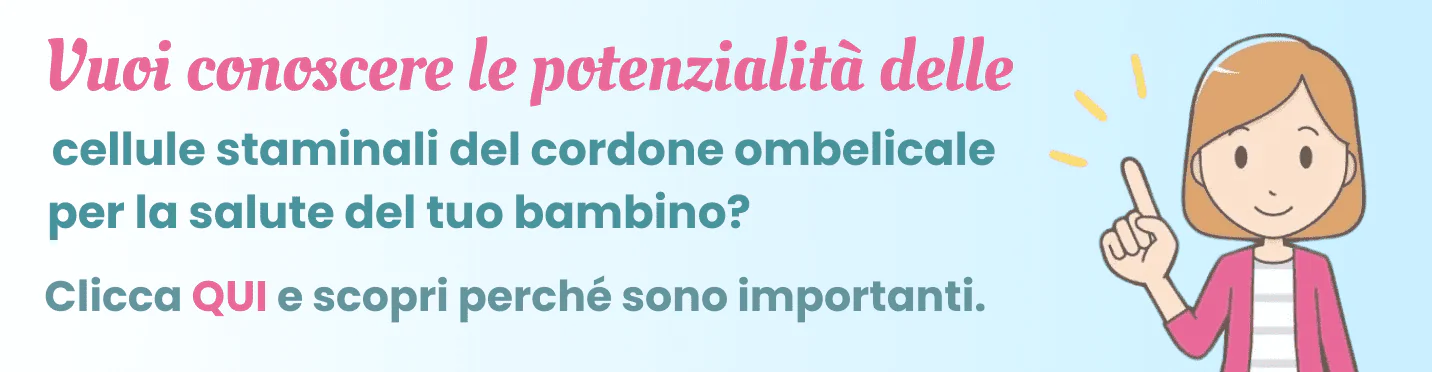Il mosaicismo è un fenomeno strettamente legato al mondo della genetica e delle anomalie cromosomiche, che potrebbe complicare la diagnosi di malattie più o meno rare. In questo articolo vedremo cos’è nel dettaglio, come si distingue dal chimerismo e quali conseguenze ha sulla salute.
Cosa si intende per “mosaico genetico” o “mosaicismo”
Se prendessimo tutte le cellule di un singolo individuo e ne esaminassimo il nucleo, dovremmo trovare sempre lo stesso patrimonio genetico. In sostanza, tutte le nostre cellule dovrebbero contenere le istruzioni dettagliate per far funzionare non solo i loro tessuti di appartenenza, ma anche tutti gli altri.
Eppure, non va sempre così.
Il “mosaico genetico” o “mosaicismo” si verifica quando ci sono patrimoni genetici diversi in un singolo individuo, tutti espressi contemporaneamente. Ciò significa che dentro una sola persona ci sono set di cellule con corredo cromosomico diverso, oppure con lo stesso corredo espresso però in modo diverso. Ad esempio, un bambino potrebbe avere un patrimonio genetico identico in tutto l’organismo, tranne che nella cute.
Inutile precisare che un fenomeno del genere può avere un grosso impatto sulla salute, non sempre prevedibile. Le conseguenze dipendono infatti da molti fattori: numero di varianti, tessuti interessati, geni colpiti, estensione del fenomeno… A seconda di tutti questi fattori, possiamo avere casi di mosaicismo del tutto asintomatici o, al contrario, varianti che provocano deficit fisici e cognitivi.
Perché si verifica
Per quanto ne sappiamo, il mosaicismo si verifica durante lo sviluppo embrionale. Dopo la fecondazione, lo zigote ottenuto inizia a dividersi in sempre più cellule, fino ad ottenere tutte quelle che formano un organismo umano. Qualche volta, si verifica un errore durante la divisione cellulare e si formano popolazioni di cellule con patrimoni genetici diversi.
In gran parte dei casi, le cellule sbagliate muoiono e non si riproducono più, lasciando spazio a quelle con il patrimonio corretto. Altre volte, l’errore rimane ma è limitato a poche cellule. Molto più raramente, si formano interi organi con patrimoni genetici diversi, se non addirittura il 50% dell’intero organismo. Ad oggi, le cause sono poco chiare.
Probabilmente, il mosaicismo è spesso frutto di anomalie sporadiche, che si manifestano casualmente e senza una vera causa. D’altra parte, può darsi che alcuni casi di mosaicismo siano causati da fattori ambientali, come l’esposizione ad agenti chimici o a radiazioni.
Mosaicismo e chimerismo: qual è la differenza?
Anche il chimerismo indica la presenza di diverse linee genetiche in un solo organismo. A differenza del mosaicismo, però, il chimerismo si verifica quando due o più zigoti si fondono in un unico embrione. Una chimera, appunto.
Mosaicismo somatico vs. Mosaicismo germinale
Pur essendo un fenomeno raro, esistono diversi tipi di mosaicismo suddivisibili in due categorie.
- Mosaicismo somatico, coinvolge solo le cellule somatiche, ovvero quelle che compongono i tessuti. In questo tipo di mosaicismo, le cellule riproduttive (gameti) sono nella norma.
- Mosaicismo germinale, che coinvolge anche le cellule riproduttive (ovuli o spermatozoi). In questi casi, i gameti presentano un corredo genetico diverso e possono trasmettere la condizione ai figli.
Talvolta, gli individui con mosaicismo germinale non soffrono di mosaicismo somatico. Ciò significa che non mostrano alcun sintomo evidente della condizione, ma possono comunque trasmetterla. Al contrario di un individuo con mosaicismo somatico ma non germinale, che non trasmetterà la sua condizione ai figli.
Cos’è la sindrome a mosaico
Non è detto che il mosaicismo diventi evidente: quando l’anomalia si presenta avanti nello sviluppo embrionale, può riguardare poche cellule e rimanere asintomatica per tutta la vita. Soprattutto, non è detto che l’anomalia sia dannosa per l’individuo. Non è sempre così, purtroppo.
In alcuni casi, le cellule del mosaico presentano un’anomalia cromosomica dannosa, causa di una sindrome riconosciuta. Ad esempio, un bambino può nascere con gruppi di cellule affette da trisomia 21 (sindrome di Down), oppure da trisomia 18 (Sindrome di Edwards). In questi casi si parla di sindrome a mosaico.
Nelle sindromi a mosaico, l’anomalia cromosomica causa della sindrome riguarda solo parte delle cellule. Ciò si potrebbe tradurre in una forma più lieve della sindrome, anche se non è detto che sia sempre così: come accennato sopra, gli effetti del mosaicismo dipendono molto dall’estensione e dai gruppi cellulari colpiti, oltre che dal tipo di anomalia.
Trisomie a mosaico
La sindrome di Down a mosaico è una delle forme più conosciute di mosaicismo. L’individuo presenta alcune cellule con la trisomia 21 (tre copie del cromosoma 21) e altre cellule con un normale corredo cromosomico. Benché la variabilità rimanga alta, questo si associa a caratteristiche cliniche più lievi, rispetto alla forma classica.
Oltre che la sindrome di Down, il mosaicismo può interessare anche altre trisomie, tra cui:
- Trisomia 18 (Sindrome di Edwards) a mosaico. La forma a mosaicismo rimane una condizione seria, ma sia associa a un tasso maggiore di sopravvivenza.
- Trisomia 13 (Sindrome di Patau) a mosaico. Il 90% dei bambini che soffrono della forma completa muore pressappoco un mese dopo la nascita. I bambini affetti dalla sindrome a mosaico hanno un tasso di sopravvivenza più alto, ma rimane una condizione grave.
Mosaicismo dei cromosomi sessuali
Un altro tipo di anomalie relativamente comuni sono quelle che interessano i cromosomi sessuali, ovvero X e Y. Proprio come nel caso delle trisomie, il mosaicismo esiste anche per le anomalie dei cromosomi sessuali.
- Sindrome di Turner a mosaico. Le donne affette da sindrome di Turner hanno una sola copia del cromosoma X, al posto della coppia di cromosomi X che dovrebbero avere. In realtà, più della metà di loro soffre della versione a mosaico della sindrome di Turner. Il mosaicismo riduce la severità di alcuni sintomi, tra cui l’infertilità: solo il 15% delle donne affette dalla sindrome riesce ad avere una gravidanza spontanea, tutte affette da mosaicismo.
- Sindrome di Klinefelter a mosaico. La versione speculare della sindrome di Turner: chi ne soffre ha un cromosoma X extra, il che provoca sintomi come basso testosterone e fibrosi testicolare. Il mosaicismo riduce la gravità della sindrome.
Il ruolo del mosaicismo nella placenta
Cosa succede se il mosaicismo interessa la placenta, un organo fondamentale per lo sviluppo del feto? Spesso non succede niente: nonostante il mosaicismo placentare, le cellule del feto rimangono normali, senza anomalie cromosomiche.
Un team di ricerca dell’Università di Cambridge ha deciso di approfondire la cosa; i risultati dello studio sono stati pubblicati su Nature nel 2021, con un aggiornamento nel 2022.
I ricercatori hanno analizzato le mutazioni presenti in 86 placente: hanno eseguito numerose micro-dissezioni su ciascuna placenta, così da prelevare il DNA proveniente da diversi punti. Analizzando i tessuti, hanno scoperto un numero elevatissimo di anomalie cromosomiche, molto più elevato di quelle che si possono riscontrare nei tessuti embrionali.
Il mosaicismo placentare riguarda circa il 2% dei campioni ottenuti con la villocentesi tra la 10a e la 12a settimana. Ciononostante, solo il 10% di quegli embrioni riporta quegli stessi difetti cromosomici.
Benché le implicazioni non siano ancora del tutto chiare, può darsi che una delle (tante) funzioni della placenta sia “spazzare via” le anomalie cromosomiche. Per citare il presidente di AOGOI Carlo Sbiroli, si potrebbe vedere la placenta come uno spazzino di difetti genetici.
Inoltre, può darsi che la placenta abbia semplicemente una soglia di controllo delle mutazioni più bassa: la placenta deve adattarsi rapidamente, il che aumenta il rischio di errori genetici. L’importante è che l’embrione mantenga una soglia di controllo più alta, per garantirne la stabilità genetica.
Mosaicismo placentare e diagnosi prenatali
Nonostante il suo possibile ruolo di spazzino, il mosaicismo placentare ha un grosso problema: complica test e diagnosi prenatali. Il DNA anomalo della placenta, infatti, può essere scambiato per DNA anomalo fetale e portare a falsi positivi negli esami prenatali.
Il rischio è particolarmente rilevante per le trisomie, le anomalie cromosomiche più rilevate dai test del DNA fetale. Ecco perché si eseguono sempre ulteriori controlli, dopo un esito positivo del test.
Rischi per lo sviluppo fetale
Un mosaicismo placentare esteso, o riguardante tessuti placentari critici, può comunque influenzare negativamente lo sviluppo fetale. Pare infatti esserci una correlazione tra mosaicismo placentare significativo e:
- restrizione della crescita intrauterina, dovuta forse a una riduzione dell’apporto di nutrienti e ossigeno al feto;
- complicazioni della gravidanza, come preeclampsia e parto pretermine.
Mosaicismo nelle cellule staminali?
Fino a questo momento abbiamo parlato del mosaicismo in organi e tessuti, ma il mosaicismo può riguardare anche le cellule staminali. Pare che il midollo osseo di 1 persona su 40 mostri segni di mosaicismo, senza però problemi di salute evidenti. Ciò significa che il mosaicismo potrebbe essere molto più comune di quanto si creda, anche se non sempre evidente. È stato perfino documentato il caso di una donna affetta da sindrome di Turner a mosaico che ha donato il suo midollo osseo.
Per quanto riguarda le staminali del cordone ombelicale, gli studi mostrano una certa stabilità genetica. Gran parte delle cellule a mosaico si concentrano nella placenta (4% di prevalenza circa), mentre il cordone ombelicale rimane pressappoco intatto (1,3% di prevalenza).
Se hai bisogno di ulteriori informazioni sulle staminali del cordone ombelicale e sul loro utilizzo, contatta Sorgente: potrai parlare con un nostro consulente senza impegno, per chiarire tutti i tuoi dubbi e imparare perché conservare il sangue cordonale può tornare utile.
Valuta l'articolo: